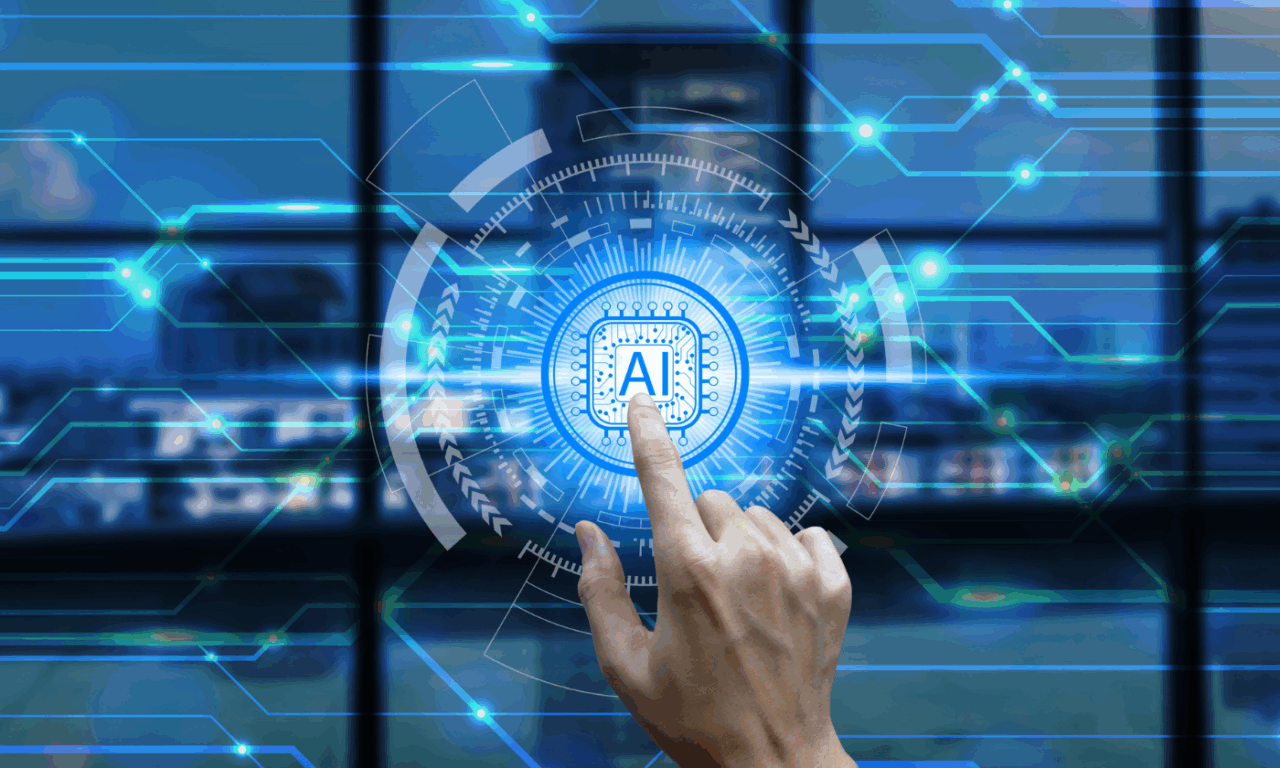Nell’epoca in cui chatbot, generatori di immagini e software predittivi sembrano diventati strumenti quotidiani, c’è chi sceglie consapevolmente di dire no.
C’è chi li ha già ribattezzati “vegani” dell’intelligenza artificiale (approfittando di un’icona di purismo integralista), ma al di là delle etichette, i critici dell’IA sono semplicemente persone che per ragioni etiche, ambientali o personali rinunciano, del tutto o in parte, all’uso delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.
Non si tratta di un rifiuto nostalgico del progresso, ma di una presa di posizione che solleva domande fondamentali: qual è il costo reale di ogni interazione digitale? E fino a che punto siamo disposti a delegare creatività e decisioni a una macchina?
Motivazioni etiche, ambientali e cognitive
La maggior parte di loro parte da motivazioni etiche. In un mondo in cui algoritmi opachi condizionano scelte politiche, lavorative e perfino personali, rinunciare all’AI diventa un modo per rivendicare l’autonomia del giudizio umano. C’è chi sottolinea i rischi legati alla raccolta massiccia di dati sensibili, chi teme una progressiva depersonalizzazione delle esperienze creative, chi mette in guardia sul fatto che un’adozione massiccia dell’AI rischia di accentuare l’esclusione sociale di chi non ha accesso o competenze digitali adeguate. Queste obiezioni non sono isolate: filosofi della tecnologia ed esperti di etica applicata le condividono da tempo, evidenziando i pericoli di una delega eccessiva a sistemi intelligenti poco trasparenti.

Ma il cuore delle critiche riguarda anche l’ambiente. I grandi modelli linguistici e i generatori di immagini richiedono data center giganteschi, server sempre accesi e GPU ad altissimo consumo. Alcuni studi stimano che l’addestramento di un singolo modello possa produrre emissioni paragonabili a decine di voli intercontinentali. Così come c’è chi riduce il consumo di carne per abbassare la propria impronta ecologica, i critici dell’AI scelgono di limitare le proprie interazioni digitali per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.
Non mancano poi le preoccupazioni di natura cognitiva. Psicologi e pedagogisti temono che un uso eccessivo dei chatbot riduca lo stimolo al ragionamento autonomo e alla creatività. Se l’utente si abitua a validare risposte preconfezionate, corre il rischio di perdere progressivamente la capacità di analizzare problemi complessi o di sperimentare nuove forme espressive.
Il dibattito inizia ad accendersi
Quello dei critici dell’IA non è un movimento marginale. Vi aderiscono tecnici, insegnanti, artisti e semplici cittadini, e la loro azione non si esaurisce nel rifiuto: cercano piuttosto di proporre un approccio diverso, fatto di moderazione e consapevolezza. Significa ridurre le interazioni superflue con i chatbot, scegliere software più leggeri e trasparenti, coltivare pratiche di creatività manuale e valorizzare il pensiero critico. In altre parole, non un no assoluto alla tecnologia, ma un invito a un uso più responsabile e sostenibile.
Oggi i critici dell’AI sono ancora una minoranza, ma le loro riflessioni stanno entrando nel dibattito pubblico e potrebbero influenzare le scelte politiche e culturali dei prossimi anni. Più che un rifiuto, la loro posizione è un monito: ci ricordano che il progresso non è autentico se non tiene conto dell’etica, dell’ambiente e della dignità delle persone.
QUI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI SUL TEMA INTELLIGENZA ARTIFICIALE