Dieci anni fa, mentre insegnava con la famiglia a La Jolla, in California, Roberto Burioni apriva il suo primo profilo Facebook per parlare di vaccini e scienza. Era l’inizio di una lunga avventura di divulgazione online che lo avrebbe reso una delle voci più note — e spesso più discusse — del dibattito scientifico italiano.
Oggi, a dieci anni di distanza, l’immunologo del San Raffaele annuncia una svolta: dirà addio ai social tradizionali per trasferire la sua attività su Substack, una piattaforma che permette di pubblicare contenuti in forma di newsletter e articoli, accessibili tramite abbonamento.
Perché lascia i social
In un post pubblicato su Facebook e X, Burioni spiega le ragioni della sua decisione.
“Quello che scrivo qui può essere usato gratuitamente per addestrare piattaforme di intelligenza artificiale,” osserva, “e io non sono disposto a regalare il mio lavoro a chi è già immensamente ricco.” Oltre al tema dell’uso dei contenuti da parte dell’IA, l’immunologo denuncia anche la natura opaca dei social network, dove “alcuni post vengono diffusi in modo massiccio e altri passano inosservati”. Un sistema che, secondo lui, risponde a logiche di visibilità decise dalle piattaforme stesse, non dal valore dei contenuti.
Ma c’è anche una dimensione personale: dopo anni di esposizione pubblica, Burioni ammette di essere “stanco di essere utilizzato come sputacchiera”. Gli insulti, spiega, non colpiscono solo lui ma anche chi gli sta intorno — studenti, colleghi e persino la figlia adolescente.
“A un certo punto bisogna dire basta.”
Substack, una nuova casa per la divulgazione
La scelta di Burioni ricade su Substack, una piattaforma nata negli Stati Uniti nel 2017 e diventata, negli ultimi anni, un punto di riferimento per giornalisti, scrittori e divulgatori che cercano indipendenza dai social tradizionali e dagli editori.
Su Substack, gli autori possono inviare i propri contenuti direttamente agli abbonati — testi, podcast, video — scegliendo se renderli gratuiti o riservarli ai soli sostenitori paganti. Il modello è semplice: la piattaforma trattiene una commissione del 10% e lascia il resto all’autore, che può costruire una comunità di lettori fedeli e dialogare con loro senza filtri algoritmici o pubblicitari.
Per Burioni, l’abbonamento sarà “irrisorio”, sotto i due euro al mese: una soglia pensata non per arricchirsi, ma per creare una barriera minima contro gli haters e garantire uno spazio di confronto civile.
“Chi vorrà sputare, dovrà comunque lasciare un numero di carta di credito,” ironizza l’immunologo.
Ha inoltre previsto un periodo di prova di sei mesi: se non raggiungerà un certo numero di abbonati, chiuderà l’esperimento “prendendo atto dello scarso interesse”.
Libertà e responsabilità
Dietro la decisione di Burioni c’è una riflessione più ampia sul ruolo della scienza e della comunicazione oggi.
“Non possiamo e non dobbiamo rinunciare alla diffusione delle notizie scientifiche corrette,” avverte Francesco Vaia, ex direttore della Prevenzione del ministero della Salute, commentando la scelta del collega. “Se gli scienziati abbandonano i social, lasciano spazio a chi diffonde fake news e posizioni antiscientifiche.”
Vaia riconosce però la centralità del tema sollevato da Burioni: l’uso dell’intelligenza artificiale e la necessità di definire che tipo di società vogliamo costruire.
“L’IA può essere un grande strumento di sviluppo, ma anche una minaccia se usata in modo fraudolento.”
Il fenomeno Substack
Substack rappresenta oggi un modello alternativo di informazione e di giornalismo. È una piattaforma facile da usare, priva di pubblicità invasiva, che permette a chi scrive di rivolgersi direttamente ai propri lettori.
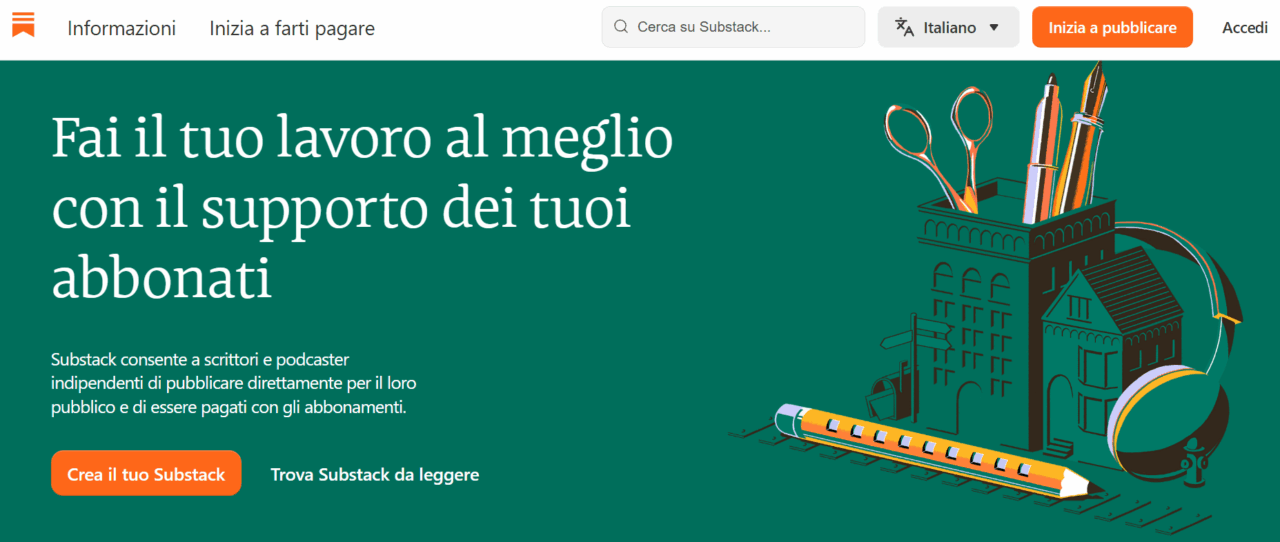
Nel mondo, conta oltre 3 milioni di abbonati paganti e continua a crescere anche in Italia, dove sempre più giornalisti la scelgono per liberarsi dai vincoli delle redazioni tradizionali.
La forza di Substack sta nella relazione diretta tra autore e lettore: la newsletter arriva via email, come una lettera personale, e crea un senso di comunità che difficilmente si ritrova nei social. Tuttavia, questa libertà comporta anche rischi: la mancanza di filtri editoriali richiede grande responsabilità individuale, e la frammentazione dei lettori in piccole “bolle” tematiche può limitare il confronto pubblico.
Con la sua scelta, Burioni diventa uno dei primi scienziati italiani a scommettere su un modello di divulgazione indipendente e sostenibile, che punta sulla qualità dei contenuti e sul rapporto di fiducia con chi legge. È un esperimento che riflette una trasformazione più profonda: la ricerca di spazi digitali dove la voce dell’autore non sia mediata da algoritmi, ma arrivi direttamente a chi sceglie di ascoltarla.
Il futuro dirà se Substack potrà davvero diventare il nuovo laboratorio della comunicazione scientifica e giornalistica. Di certo, la decisione del noto divulgatore segna un passaggio simbolico: la scienza, per restare libera, deve trovare nuovi luoghi dove farsi ascoltare — e, forse, imparare a scrivere di nuovo come se parlasse a una persona, non a una folla.


