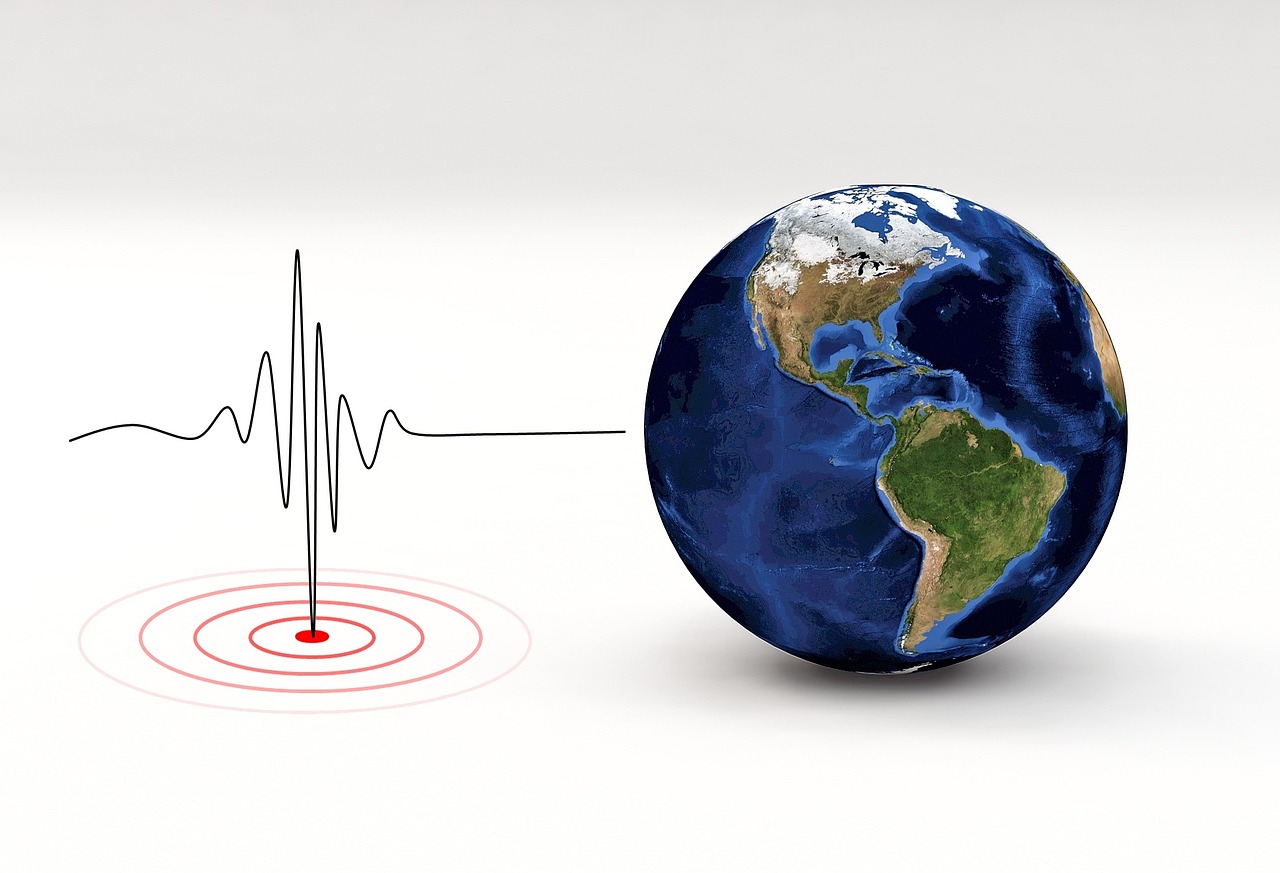Il tema della prevenzione sismica in Italia rappresenta una delle più urgenti priorità per la sicurezza della popolazione e la tutela del patrimonio storico e civile.
La nostra penisola, pur non figurando tra le aree del mondo soggette ai terremoti più violenti in termini di magnitudo, è tristemente presente nei primi posti delle classifiche mondiali per numero di vittime causate da eventi sismici. Questo apparente paradosso è in realtà spiegabile, e proprio nella sua comprensione risiede la chiave per avviare politiche efficaci di prevenzione.
Il rischio sismico
Conoscere il rischio sismico è il presupposto per parlare di prevenzione e per costruire il futuro. Non è definito solamente dalla forza del terremoto, ma da tre componenti fondamentali:
- la pericolosità sismica, ovvero la probabilità che si verifichi un terremoto di una certa intensità in una determinata area;
- la vulnerabilità sismica, che rappresenta la capacità – o fragilità – delle strutture esistenti nel resistere alle scosse;
- l’esposizione, ossia il valore economico e sociale degli edifici e dei beni (compresi, naturalmente, gli esseri umani) esposti a quel rischio.
Un terremoto anche non particolarmente violento può trasformarsi in una tragedia immane se colpisce un’area ad alta densità abitativa, con edifici vulnerabili e assenza di preparazione.
I terremoti più forti
L’analisi dei terremoti più forti registrati nella storia recente e remota mostra come la maggior parte di questi si siano verificati nelle aree più instabili del Pianeta: la cintura di fuoco del Pacifico, il sud-est asiatico, e le coste dell’America Latina. Il più potente mai registrato è quello di Valdivia, in Cile, del 22 maggio 1960, con una magnitudo di 9,5.
A seguire troviamo eventi devastanti come il terremoto dell’Oceano Indiano del 2004 (M 9,1–9,3), quello dell’Alaska del 1964 (M 9,1), e quello del Giappone – Tōhoku del 2011 (M 9,0), tristemente noto anche per il disastro nucleare di Fukushima. In totale, si contano almeno 40 terremoti noti con magnitudo superiore a 8,0. Nessuno di questi ha avuto luogo in Italia.
Il tema della vulnerabilità
La vulnerabilità uccide: se, infatti, osserviamo la classifica dei terremoti che hanno causato il maggior numero di vittime, il quadro cambia radicalmente.
Al primo posto si trova l’evento più letale della storia umana: il terremoto della provincia di Shensi (Cina) del 1556, che costò la vita a circa 830.000 persone. Seguono altri eventi devastanti in Asia e Medio Oriente, molti dei quali con magnitudo inferiore a 8,0. L’unico evento comune alle due classifiche è quello di Sumatra del 2004, che causò circa 230.000 vittime.
Questo fatto, cruciale, conferma che non è la magnitudo in sé a determinare la catastrofe, bensì il contesto in cui l’evento avviene: edifici non progettati per resistere, popolazione ignara o impreparata, assenza di infrastrutture adeguate.
In Italia, i terremoti non raggiungono magnitudo catastrofiche su scala globale: i più violenti registrati storicamente non superano magnitudo 7,3 (come nel caso del terremoto della Val di Noto del 1693 e quello dell’Italia centro-meridionale del 1456). Tuttavia, l’impatto umano e materiale di questi eventi è stato tra i più gravi al mondo. Il terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, con una magnitudo stimata di 7,1, provocò circa 100.000 vittime. È ancora oggi il dodicesimo terremoto più mortale nella storia umana, e il più tragico mai registrato in Europa. Altri eventi italiani con decine di migliaia di morti includono: Val di Noto (Sicilia) nel 1693, con circa 60.000 morti; Avezzano (Abruzzo) nel 1915, con oltre 30.000 morti; Irpinia e Sannio nel 1456, con circa 30.000 morti.
Si tratta di cifre drammatiche, che dimostrano quanto fragile sia stato – e in parte sia ancora – il patrimonio edilizio italiano di fronte agli eventi sismici.
Responsabilità collettiva
La responsabilità è collettiva: urbanizzazione spesso disordinata, scarsa cultura della prevenzione, assenza storica di normative sismiche (o loro tardiva applicazione), ritardi nella messa in sicurezza degli edifici esistenti, e uso limitato di tecnologie antisismiche all’avanguardia, come l’isolamento sismico.
Se confrontiamo l’Italia con il Giappone, ad esempio, notiamo che questo ha una pericolosità sismica ben più alta, ma un numero di vittime mediamente molto più basso, grazie a un sistema normativo severo, investimenti pubblici continui e una forte consapevolezza collettiva del rischio.
Una proposta per il futuro è di costruire con intelligenza; l’unico modo per evitare nuove tragedie è investire con decisione e urgenza nella prevenzione, con:
- messa in sicurezza e adeguamento sismico del patrimonio edilizio, soprattutto pubblico e scolastico;
- adozione di tecnologie avanzate, come l’isolamento sismico alla base per edifici strategici;
- formazione continua per cittadini, professionisti e amministratori;
- una mappatura aggiornata della vulnerabilità edilizia;
- maggiore impegno su piani urbanistici che tengano conto del rischio sismico, e non lo ignorino.
Non servono altri allarmi, servono decisioni.
Le catastrofi del passato insegnano che non si possono fermare i terremoti, ma si possono fermare le stragi. L’Italia non può più permettersi di ignorare la propria storia sismica. Ogni scossa che fa crollare una scuola, un ospedale, una casa abitata, rappresenta una sconfitta della politica e della cultura della prevenzione.
Occorre cambiare approccio: non reagire dopo il disastro, ma agire prima. La tecnologia esiste, le competenze ci sono, le risorse devono essere trovate. È una questione di responsabilità, di civiltà e, soprattutto, di rispetto per le vite umane.